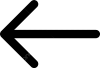
Sembrano due «uomini di buona volontà»,
il vecchio
e il giovane
seduti di fronte.

Stavolta è il presidente ucraino Zelensky quello con l’abito giusto, in nero e senza divisa militare; mentre il blu cobalto di Donald Trump non è esattamente il dress-code che era stato raccomandato dal Vaticano. Ma che importa? Lo scatto è storico. Piegati l’uno verso l’altro, su due semplici sedie,con le teste che quasi si toccano come in una confessione, nel mezzo di San Pietro, sullo sfondo una raffigurazione del battesimo di Cristo. Visto di profilo, il presidente americano sembra portare sulle spalle un peso, di anni e forse di responsabilità, che nello Studio Ovale placcato d’oro come un Country Club facilmente nasconde dietro una posa imperial-macho, appollaiato sulla punta della sua poltrona presidenziale. Zelensky, dal canto suo, ha un atteggiamento umile, sofferente, implorante; ma non spaventato come l’altra volta. Sarà che non c’era il «mastino-in-chief», JD Vance. Oppure sarà stata la mano di Dio. Ma questa foto
sembra già un miracolo. L’ultimo di Francesco? È ancora presto per dirlo. Potrebbe però essere l’inizio di quella «onesta trattativa» per la pace in Ucraina, auspicata con parole appropriate dal cardinal Re nella sua omelia in piazza. Innanzitutto perché i due, chiaramente, si sono ascoltati. Si vedeva dal body language, dalla gestualità delle mani, dalle sopracciglia aggrottate nello sforzo di comprendere l’altro, più che di esibire sé stesso.
Certo, c’è sempre dimezzo Putin. Lui, che la guerra l’ha cominciata, in San Pietro non ci può neanche entrare. In quegli stessi minuti stava infatti parlando di battaglie, non di pace. Annunciava da Mosca l’ennesimo successo sul campo nel Kursk, mentre il Cremlino ringraziava i poveri fantaccini nordcoreani, mandati a morire a migliaia di chilometri di distanza da casa, al servizio del neo-colonialismo russo.
Del resto, solo in San Pietro un incontro così straordinario poteva accadere. Ieri abbiamo visto di quante divisioni disponga il Papa: un patrimonio di autorità morale, influenza planetaria, proiezione universale che la Chiesa, pur con tutti i suoi umanissimi difetti e limiti, esercita ancora, come ormai nessun’altra organizzazione al mondo. È per questo che Roma è eterna, e conta ancora qualcosa nel mondo. Tutta quella gente, potenti di ogni nazione, compresi quelli che il Papa aveva preso a sberle («Chi costruisce muri e non ponti non può dirsi cristiano» era riferito a Trump). E tutta quella gente in piazza e per le strade di Roma, commossa e partecipe. Certo, sono venuti per Francesco, un uomo eccezionale sotto ogni aspetto. Per salutare le sue scarpe nere e il suo cuore candido. Nell’era dell’immagine anche i pontefici devono averne una che parli «urbi et orbi».
Ma Francesco è stato ciò che è stato perché era il capo di Santa Romana Chiesa. Quella stessa che abbiamo visto ieri rappresentare la sua liturgia millenaria, la messa in latino, l’incenso e i turiboli, le cotte e le mitre, la transustanziazione e la comunione, tutte quelle cose che di solito critichiamo perché sorpassate, non adatte ai tempi, aristocratico segno di distacco dalla realtà; e però, in fin dei conti, essenziali per esprimere la sostanza del messaggio cristiano. Che non è «vogliamoci bene», questo può dirlo chiunque; ma consiste nell’annuncio della salvezza per l’umanità, perché «Cristo morì per i nostri peccati e fu sepolto e resuscitò il terzo giorno», e così fece entrare nella storia dell’uomo il Regno di Dio, con la promessa della Resurrezione.
Dalla morte di Francesco fino a ieri, ci siamo tutti molto occupati di ciò che lui faceva nell’aldiquà. Dei poveri e degli ultimi ai quali sapeva parlare; delle guerre e dello sfruttamento dell’ambiente che sapeva condannare; dei migranti che, discendente di emigrati italiani egli stesso, voleva accogliere e abbracciare. Ma accompagnandolo nell’ultimo viaggio, ieri la Chiesa e i suoi fedeli hanno aperto una finestra sull’aldilà in cui è andato, e sul suo mistero: non è obbligatorio crederci per sentire la forza di redenzione che sprigiona. Se un cardinale poté convertire l’Innominato, volete che un Papa non possa convertire chi si fa la guerra? La Chiesa tratta una merce rara, si chiama speranza.
Per un caso del destino, o per un disegno divino, le esequie di Francesco sono coincise con il Giubileo degli adolescenti, e così ieri Roma era invasa da decine di migliaia di giovani, così clamorosamente diversi dai coetanei protagonisti delle nostre cronache nere. Portavano in petto il motto del Giubileo, «Peregrinantes in spem». Con le loro magliette verdi, sotto il cielo azzurro della Capitale, anche più del rosso porpora dei cardinali, rappresentavano quel «popolo di Dio» che—ha concluso il cardinal Re — «tiene alta la fiaccola della speranza».
La loro e la nostra.
Antonio Polito, Corriere della sera, 27.04.2025